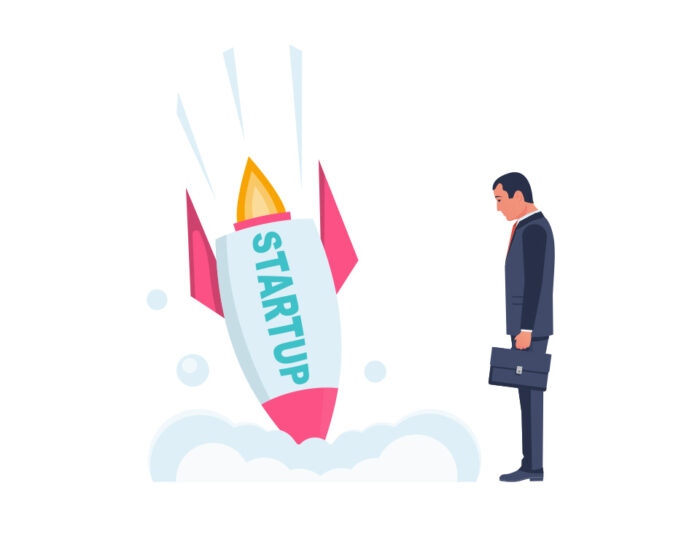“Non si impegna abbastanza!”: il sintomo di una malattia diffusa
Un’idea che viene da lontano
Il nostro modello scolastico si basa sull’idea che lo studente si debba concentrare sulle materie ove ha i voti peggiori. Ai miei tempi gli studenti con l’insufficienza venivano rimandati a settembre. Bisognava passare l’estate a ripassare proprio quella materia per la quale avevamo meno attitudine. Si pagavano professori o studenti universitari per le ripetizioni con l’obiettivo di strappare un sei; la maggior parte dei rimandati se la cavavano, in quanto i docenti incaricati di valutare abbassavano l’asticella affinché non venisse perso un anno.
Il sistema raramente generava il risultato voluto, ma quantomeno veicolava una morale visto che gli studenti diligenti potevano godersi le vacanze mentre i rimandati passavano l’estate con la spada di Damocle sopra la testa…
Le ripetizioni forzate, a meno di rare eccezioni, avevano un sicuro effetto: trasformare l’antipatia per la materia in odio totale!
Il primo governo Berlusconi-Bossi, nel suo breve periodo di vita, introdusse il sistema dei debiti, che manteneva l’impianto culturale precedente, basato sull’idea di investire nell’area di deficit, ma lo rendeva perverso e ingestibile.
Dalla frequentazione dei patri Istituti Scolastici ci portiamo a casa, più o meno consapevolmente, l’idea che il modello educativo migliore sia quello ove bisogna sforzarsi di più nella materia dove si ha meno inclinazione.
Dalla scuola alle imprese, una pesante eredità
L’imprinting scolastico si trasferisce nelle imprese, ove ci adoperiamo per la riduzione dei deficit anche nei casi ove la mancanza di attitudine sconsiglia ogni investimento, ciò che genera costi:
- diretti:
- focus, formazione, coaching improduttivi richiedono tempo e soldi;
- il tempo impiegato nella direzione sbagliata viene sottratto allo sviluppo del potenziale,
- indiretti:
- si riduce l’autostima della persona e nel tempo la disponibilità ad investire nella crescita[1],
- si riduce la fiducia nel management, poiché il fallimento dei piani di sviluppo deteriora la relazione tra capo e collaboratore.
Perché insistiamo nella direzione sbagliata?
L’ostinazione a fare saltare i coccodrilli e a fare strisciare le giraffe[2] ha molte radici, tra le quali:
1) La spiegazione più immediata per un deficit di prestazione è la mancanza di volontà.
Media e internet quotidianamente divulgano storie di persone che sono riuscite a raggiungere risultati impensabili superando un deficit. Atleti con handicap fisici che hanno stabilito record dichiarano: “La forza di volontà permette di superare qualsiasi ostacolo” oppure “Chiunque può diventare campione con impegno e disciplina”, fino alla sintesi stelle e strisce: “Se lo vuoi veramente, ci riuscirai”.
Si radica così la convinzione che chiunque possa raggiungere il successo grazie all’abnegazione, ove è invece dimostrato che i campioni mettono semplicemente a frutto ciò che hanno naturalmente dentro di loro.
Se pensiamo a quanto siano rari i giocatori MBA alti meno di un metro e settanta comprendiamo quanto sia insensato puntare alla replicazione di ciò che, per sua natura, è fenomenale.
Più sostenibile invece sfruttare le qualità naturali delle persone; parafrasando Markus Buckingham, visto che già è difficile tirare fuori quello che c’è nelle persone, perché dovremmo sforzarci di sviluppare quello che non c’è”[3].
2) L’accanimento per ottenere l’uovo procrastina il chiarimento con noi stessi: non abbiamo selezionato una gallina. Tutti i tentativi di motivare, formare, sviluppare chi non può dare quel risultato ci difendono dall’assunzione di responsabilità: non è il collaboratore ad avere sbagliato!
3) Non siamo in grado di fare un inventario delle risorse del collaboratore con rendimento insoddisfacente. Mettiamo pressione perché non comprendiamo quali siano le attitudini, ciò che permetterebbe l’attivazione immediata di un piano B, ovvero un ri-orientamento.
4) Quando il deficit di attitudine si chiarisce non c’è poi la capacità di impostare un percorso di riorientamento.
Il “coaching out”, ovvero il processo che parte dall’analisi di una performance insoddisfacente per arrivare ad una ricollocazione, è scomparso dai piani formativi. Un supervisore non formato si basa sul famigerato buon senso, che deriva dall’applicazione casuale di metodi visti al cinema oppure derivati dalle trasmissioni sportive.
Prevenzione e gestione dei casi di “low performer”
La gestione del personale che non offre una performance soddisfacente è una disciplina tecnica, che richiede una conoscenza specifica. Un’organizzazione ove la funzione HR opera per la prevenzione ha concreti e misurabili vantaggi economici. Solo una gestione consapevole permette di evitare danni diretti (contenziosi) ed indiretti (impatto negativo sull’immagine dei capi).
La strada più economica passa da alcuni punti fermi:
1) Coerenza tra potere e responsabilità
Quando il collaboratore viene visto come responsabile principale della performance non è possibile individuare l’errore di gestione.
La motivazione a supportare la squadra è genetica, dunque le performance scadenti rimandano a poche cause:
- condizioni di salute invalidanti;
- errore di selezione;
- errore nel piano di sviluppo;
- supervisione scadente;
- demotivazione causata da cattivo Teamwork.
Ad esclusione delle condizioni di salute, tutti i punti sono riconducibili, più o meno direttamente, ad un errore manageriale.
La gestione dei casi problematici inizia quindi con una presa in carico della responsabilità, che si concretizza in una disponibilità a mettere a disposizione risorse per il percorso.
2) Formare i supervisori a gestire le performance non soddisfacenti.
I capi che osservano i collaboratori in azione generano informazioni di qualità per la funzione HR (modello di Performance Management), ciò che è molto diverso dal processo che parte dagli indicatori per arrivare alla compilazione di una pagella da girare agli specialisti HR (Performance Appraisal).
Tempo e risorse spese per uno sviluppo delle competenze si ripagano esponenzialmente nel conto economico.
I capi vanno formati ad affrontare il processo di riorientamento del personale inquadrato in un ruolo non adatto. I benefici vanno oltre la gestione dei casi problematici, in quando i temi trattati migliorano la padronanza nella supervisione di ogni collaboratore, indipendentemente dal livello della prestazione.
Ne deriva un clima di maggior rispetto tra le parti, premessa per affrontare economicamente anche le situazioni più difficili.
3) Impostare un processo di selezione del personale a prova di errore.
La prevenzione della performance insoddisfacente, primo obiettivo della funzione HR, si fonda sull’inventario precoce delle risorse personali, che deve concludersi entro il periodo di prova. Visto che gli specialisti HR, per quanto preparati, non possono che avvalersi delle informazioni veicolate dai supervisori, occorrono modelli precisi e linguaggio condiviso.
Conclusione: performance management vs. performance appraisal
Le ricerche relative all’agenda dei supervisori dicono che è in costante aumento il tempo impiegato in adempimenti burocratici, in riunioni a scarso valore aggiunto, mentre si riduce il tempo investito nelle attività più strategiche e nella supervisione dei collaboratori.
L’affiancamento, ovvero l’osservazione diretta della prestazione, è ormai un termine del passato, in particolare:
- nell’organizzazioni matriciali,
- negli uffici[4].
È difficile immaginare una gestione del personale efficiente basata su indicatori indiretti, cruscotti che mischiano l’allineamento con i valori aziendali e risultati oggettivi.
Il trend attuale, ove il modello di performance appraisal (valutazione della prestazione tramite indicatori) sta sostituendo la logica del performance management (gestione della prestazione tramite la supervisione) correla con la qualità dei processi di gestione del personale.
L’analisi di una performance insoddisfacente che si conclude con un “Non si impegna abbastanza” segnala la necessità di aggiornare modello e processi.
Note
[1] D. Leigh, “The group trainer’s handbook”, Kogan Page 2006.
[2] Devo questa metafora alla creatività di un partecipante ad un corso sulla supervisione dei collaboratori.
[3] M. Buckingham-E. Cofmann, “Primo, rompere le regole”, Baldini & Castoldi (non disponibile in libreria da anni).
[4] I capi di persone che lavorano al computer NON si siedono di fianco al collaboratore. È una costante che resiste ad ogni intervento formativo.
Articolo a cura di Luigi Rigolio

Docente di Marketing Sanitario presso l'Università dell'Insubria.